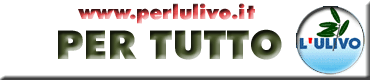
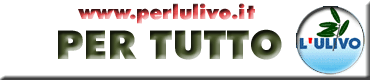
LE RETI CIVICHE
Linee guida per la loro promozione e realizzazione
A cura di:
Regione Lombardia - Direzione Generale Cultura, A.I.Re.C - Associazione Informatica e Reti Civiche Lombardia, Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze dell'Informazione - Laboratorio di Informatica Civica
INDICE
Capitolo 1 Internet e le Reti Civiche
*1.1 Le funzionalità di una rete telematica
*1.2 Rotture
*1.3 Da Internet alle Reti Civiche
*1.4 Tipologia e dimensioni
*1.5 Definizione e caratterizzazione di Rete Civica
*1.6 Reti Civiche, servizio universale e rapporto con gli Internet Providers
*Capitolo 2 Architettura tecnologica e organizzazione sociale nel progetto di una rete civica
*2.1 Architettura di una rete civica
*2.1.1 Accesso via modem e via Internet
*2.1.2 Accesso a database
*2.1.3 Collegamenti con altre reti o server
*2.1.4 E-mail Internet
*2.1.5 Aree informative
*2.1.6 Aree di discussione
*2.2 L'organizzazione sociale della comunità telematica
*2.2.1 L'identificazione degli utenti in Internet e nelle reti civiche
*2.2.2 Da utenti a progettisti di servizi
*2.2.3 I moderatori
*2.2.4 La condivisione di regole di "buon comportamento telematico"
*Capitolo 3 Possibili implementazioni
*3.1 Possibili implementazioni di una rete civica
*3.2 Configurazione tecnologica minima
*3.2.1 Hardware
*3.2.2 Linee e connessioni
*Capitolo 4 Amministrazione di una rete civica: aspetti critici
*4.1 Aspetti tecnici
*4.2 Aspetti di gestione degli utenti
*4.3 Aspetti giuridici
*Appendici
*A. Il Galateo della Rete Civica di Milano
*B. Documentazione su A.I.Re.C.
*Lo sviluppo del "fenomeno Reti Civiche" in Italia non ha forse uguali in Europa, e si caratterizza, fin dalle prime esperienze (Rete Civica di Milano, avviata nel settembre 1994; Iperbole a Bologna, avviata nel gennaio 1995) per il forte bisogno che si esprime di partecipazione da parte dei cittadini, e quindi di trasparenza, possibilità di interazione con pubblici amministratori e funzionari, e anche di creazione di una rete di cittadini che insieme abbiano maggiore possibilità di "contare", di far valere le proprie esigenze e ragioni. Questo è ovviamente legato alla situazione più generale del Paese e può essere oggetto di una lettura di carattere socio-politico. Ma ha anche radici specifiche nel nostro Paese: al contrario che oltre Oceano, dove le città non definiscono una comunità, e questa viene (ri)scoperta di recente come strumento per far fronte alla disgregazione sociale da una parte e alla globalizzazione dall'altra, da noi, dove la nozione di comunità locale, centrata intorno ad un campanile o intorno ad un Municipio, ha una tradizione di secoli e secoli, si tratta piuttosto di preservarla nella nuova società dell'informazione. Le reti civiche sono parse a molti uno (e ovviamente non "lo") strumento utile in questa direzione.
La Lombardia ha visto dapprima l'avvio della prima (in ordine di tempo) rete civica italiana: RCM, Rete Civica di Milano, promossa dal Dipartimento di Scienze dell'Informazione dell'Università degli Studi di Milano, e avviata nel settembre 1994. Ma altre ne sono seguite in un breve arco di tempo, e questo ha fatto sì che, nel dicembre del 1996 la Regione Lombardia, riconoscendo l'interesse e il valore di tali iniziative, promuovesse l'AIReC, con l'obiettivo di favorire il consolidamento delle iniziative già avviate e l'avvio di nuove.
Con il 1999, la Regione Lombardia in coerenza con i propri obiettivi strategici riferiti al Programma Regionale di Sviluppo della VI Legislatura, Progetto strategico 1. "Autonomia della Regione", area di progetto 1.3 "Enti locali", attività di progetto 1.3.1 "Sistema Informativo per le autonomie locali (SIAL)" e Progetto strategico 2. "Sburocratizzazione, trasparenza e comunicazione", area di progetto 2.3 "Comunicazione", attività di progetto 2.3.7 "Sistema di diffusione e scambio delle informazioni tramite la Rete Culturale Regionale e le reti civiche" ha deciso di includere nei criteri di valutazione dei progetti di sistemi informativi delle autonomie locali, presentati per il cofinanziamento regionale, anche gli aspetti legati alla implementazione di sistemi telematici per la comunicazione con i cittadini e le reti civiche.
Questo documento vuole essere, quindi, un ausilio per la progettazione di quest'ultima parte del sistema informativo comunale. Contiene elementi tecnici, ma non è un testo tecnico, si propone, infatti, esclusivamente di inquadrare in modo più generale l'argomento.
Capitolo 1
Internet e le Reti Civiche
Prima di entrare nel merito e precisare qual è la nozione di rete civica a cui, nella nostra esperienza facciamo, riferimento, è bene dedicare un attimo di attenzione alla caratterizzazione del fenomeno più generale, quello della evoluzione che ha portato dall'informatica alla telematica e, in tale contesto, al diffondersi di Internet, spesso identificata con il Web, ma che è invece costituita da una più ampia gamma di applicazioni.
1.1 Le funzionalità di una rete telematica.1. Le funzionalità di una rete telematica;
E' oggi sotto gli occhi di tutti che i moderni sistemi di calcolo (personal computer e workstation connessi in rete tra loro) costituiscono uno straordinario strumento generalizzato di comunicazione. Strumento, certo infinitamente più potente di ogni altro strumento, ma pur sempre artefatto, creazione degli esseri umani che viene da questi utilizzato, come gli altri strumenti sviluppati nel corso dei secoli, in ultima istanza, per migliorare la qualità della vita. E poiché oggi la vita, degli individui e delle organizzazioni, è sempre più fatta di comunicazione, il computer è utile perché unifica, arricchendole, le varie forme di comunicare fin qui note, attraverso una gamma di applicazioni che erroneamente vengono spesso identificate in un tutt'uno chiamato Internet.
- La posta elettronica si sostituisce e integra telefono e fax; dà la possibilità di inviare un messaggio (una lettera elettronica) ad uno o più individui di cui si conosce l'indirizzo elettronico (esattamente come per telefonare o mandare un fax dobbiamo conoscere il numero esatto). Come la lettera scritta e il fax, e a differenza del telefono, è una forma di comunicazione asincrona: non è necessaria la contemporanea disponibilità a comunicare di chi manda e di chi riceve, cioè l'atto di invio e di lettura non avvengono allo stesso tempo. Ciò rende la posta elettronica, per chi comincia ad utilizzarla, un insostituibile strumento di lavoro, anche perché al messaggio è possibile "attaccare" un qualsivoglia documento (o file) creato sul PC di chi manda: chi lo riceve lo "scarica" e può leggerlo, modificarlo e quindi ri-inviarlo a chi vuole.
- Le conferenze elettroniche, i newsgroup, e le liste di discussione, o mailing list, consentono di rivolgersi (sempre inviando messaggi con eventuali documenti allegati) non ad un insieme predefinito e conosciuto di interlocutori, ma a tutti coloro che sono interessati ad un certo tema, o che lo saranno, che sono interessati e disponibili a condividere informazioni o scambiare opinioni e dialogare sulle informazioni condivise, arricchendole di esperienze d'uso; possono diventare occasione di incontro tra chi produce e chi vuole acquistare, tra chi ha un figlio down o un genitore alzheimer, tra i cultori di Quasimodo, quelli dei Beatles o i fans di X-files. Esse costituiscono anche una banca dati tematica, su cui la ricerca di informazioni può essere fatta con tecniche, già sperimentate, di trattamento del linguaggio naturale. Sono queste le funzionalità più utilizzate all'interno delle Bbs (Bulletin Board System), che di fatto costituiscono delle grandi bacheche elettroniche.
- Le aree di chat, che in ambienti tutti orientati, come si è detto a sfruttare i vantaggi della comunicazione asincrona, preservano uno spazio per la comunicazione sincrona (sia pure scritta) con coloro che sono in quel momento collegati alla rete; sono utilizzati anche per fornire supporto on-line.
- Il World Wide Web, tecnologicamente: le reti+l'ipertestualità+la multimedialità; nei fatti una galleria di idee, informazioni, prodotti e servizi su scala mondiale, biblioteca e libreria, supermercato, radio e televisione. Ma sempre (in teoria, in futuro) con la possibilità di entrare in contatto diretto e personale con chi ha aperto la vetrina.
L'insieme di queste tecnologie, utilizzate da parte di una struttura organizzativa (sia esso un Ufficio, un settore di un Ente Pubblico, un'Associazione no profit o un'Azienda), costituiscono, al suo interno, uno strumento efficace di coordinamento delle attività e di banca dati condivisa, che risulta particolarmente vantaggioso se, come sempre più spesso accade, la struttura stessa opera su diverse sedi distribuite sul territorio e se il tipo di lavoro porta sovente i suoi membri a non essere contemporaneamente presenti in sede.
E al tempo stesso, favoriscono la comunicazione dell'ente con l'esterno, non soltanto in modalità broadcast (cioè per la mera diffusione di informazioni) ma con quella possibilità di dialogo e scambi interattivi che facilita il formarsi di un proficuo rapporto con un'utenza attiva e dà la possibilità di recepire apprezzamenti, consigli e lamentele per migliorare costantemente servizi e prodotti.
Non a caso, oggi, il futuro di Internet negli ambienti professionali, viene sempre più affidato al binomio: Intranet+Extranet.
1.2 Rotture.2 Rotture;
Va tuttavia osservato che lo sviluppo, anzi l'esplosione, delle reti, e di Internet in particolare, ha avuto alcune caratteristiche che sono all'opposto dei modelli di riferimento che la società oggi propone:
- la rete è per sua natura intrinsecamente aperta, in una società vincolata dalle appartenenze, e quindi tipicamente chiusa;
- lo sviluppo della rete avviene dal basso (bottom-up), non c'è un progetto o un piano che qualcuno ha steso e cerca di attuare (top-down); i gruppi di discussione vengono attivati sulla base dell'iniziativa di volontari che condividono un certo interesse;
- in una società oggi permeata da media (la TV prima tra tutti) che si rivolgono ad una massa di utenti passivi, la telematica - intrinsecamente interattiva - promuove la crescita di individui attivi;
- promuove la cooperazione, lo scambio, la condivisione di conoscenza, il dialogo; anche in un contesto competitivo si propone come terreno di condivisione pre-competitiva, affidando al mercato la selezione successiva;
- in una cultura dominata dalle immagini, posta elettronica e gruppi di discussione ridanno, diversamente dal Web, valore alla parola scritta;
- in un mondo ancora retto essenzialmente da organizzazioni gerarchiche, che però ovunque scricchiolano (bastino come esempi le grandi holding, i partiti e gli stati centrali), rende possibile l'appiattimento delle organizzazioni, il loro strutturarsi a rete, poiché fornisce una tecnologia che consente di governare l'overhead di comunicazione.
Tutti questi elementi concorrono a determinare un momento, quello attuale, in cui si opera una trasformazione che ha ritmi e dimensioni vertiginosi. Quando si determinano situazioni di questo tipo prevedere ciò che accadrà domani è pressocché impossibile, anche perché non c'è un unico esito possibile. L'unico fatto certo è che l'importante è esserci, perché chi rimane fuori, rimane tagliato fuori. Individui e organizzazioni che non apprendono la nuova lingua sono destinati all'emarginazione.
Mettere tutti, ma specialmente i giovani, nelle condizioni di affrontare questo cambiamento, è quindi come affermare il diritto alla sopravvivenza: è un diritto di tutti poter accedere a questa nuova conoscenza e concorrere a questa trasformazione. Ma, proprio per la natura del fenomeno, la formazione non può limitarsi all'insegnamento di qualche tecnica, di alcuni strumenti (il modem) o di qualche pacchetto software, e passa necessariamente per l'esperienza diretta.
1.3 Da Internet alle Reti Civiche.3 Da Internet alle Reti Civiche;
Negli Stati Uniti, dopo la nascita di Internet nel mondo della difesa e la sua diffusione nel mondo della ricerca, la definitiva esplosione si è avuta con la disponibilità di Internet per i privati, attraverso gli Internet providers. Ma a fianco dello sviluppo commerciale, la possibilità da parte di chiunque di "entrare in rete" e di apprenderne per esperienza diretta l'uso e le potenzialità, è stato garantito anche dal diffondersi delle reti civiche, che hanno valorizzato le esperienze di informatica sociale di tante Bbs amatoriali.
Le reti civiche si sviluppano in Nord America (Stati Uniti e Canada) a partire dalla seconda metà degli anni '80, cioè quando - è bene sottolinearlo - il Web ancora non esiste e dunque Internet è posta eletronica, mailing list, news, chatting (interazione "in diretta" con altri utenti in quel momento collegati allo stesso nodo). Le Rc nascono spesso dalle Università o dalle Biblioteche pubbliche, per offrire a tutte le componenti di una comunità locale le opportunità che le reti telematiche in generale, ed Internet in particolare, offre - gratuitamente - ai membri della comunità scientifica e - a pagamento - agli utenti delle reti commerciali.
Sono quindi sorta di "Internet locali", caratterizzate dall'attenzione alla comunicazione bidirezionale, al fatto che il contenuto informativo sia fornito anche dagli stessi utenti (sullo stile dei newsgroup di Internet) e alle tematiche di interesse locale. Stando ad un documento del Center for Civic Networking, le reti civiche, proprio in quanto radicate in una specifica comunità locale, contribuiscono tra l'altro a: rivitalizzare le economie locali, ridurre i costi sociali della disoccupazione e della chiusura delle imprese; migliorare i servizi, ridurre i costi di governo; rivitalizzare le Istituzioni Civiche e il dibattito pubblico; ridurre la povertà e modificare il wellfare; ridurre i costi per la Sanità, migliorare la prevenzione e la diagnosi delle malattie; portare l'educazione dei giovani nel XXI secolo; ridurre i costi dell'inquinamento, della manutenzione delle strade e della cura dei piccoli.
1.4 Tipologia e dimensioni.4 Tipologia e dimensioni;
Sotto il termine italiano di "reti civiche" si denotano esperienze significativamente diverse tra loro, per obiettivi e tecnologie.
Le free nets, cioè reti libere e gratuite (dette anche community networks), che potrebbero essere tradotte come "reti dei cittadini", nascono dall'esperienza iniziata a Cleveland (1984) da Tom Grunder, medico presso il Dipartimento di Medicina della Case Western Reserve Univerity, che attiva una Bbs, divenuta famosa sotto il nome di "St. Silicon Hospital". La Bbs inizialmente doveva servire a studenti e cittadini per risolvere dubbi di carattere medico, anche attraverso la consultazioni di archivi on-line. Ma subito ci si accorge che ciò che davvero interessa e serve è la possibilità di interagire da una parte con i medici e dall'altra tra persone, pazienti e loro parenti, che vivono situazioni analoghe. Il successo è tale che la Bbs si estende a tematiche non solamente medico-sanitarie: nasce così (1986) la Freenet di Cleveland ed il software utilizzato, Free Port, diviene rapidamente lo standard per il movimento delle Freenets, molte delle quali, collegate in rete tra loro, danno luogo alla NPTN (National Public Telecomputing Network).
Le civic nets, reti civiche in senso stretto (in italiano forse più corrispondenti a quelle esperienze che si sono chiamate "Servizio Telematico Pubblico"), sono invece promosse dalle Amministrazioni per fornire per via telematica informazioni e servizi di pubblica utilità. Ne è prototipo il PEN (Public Electronic Network) di Santa Monica, California che, oltre ai servizi broadcast, offre ai cittadini la possibilità di comunicare all'Amministrazione bisogni, opinioni, richieste.
Con l'affermarsi del Web, si fa avanti la volontà delle città di "mettersi in vetrina" per farsi conoscere. Le informazioni rese disponibili hanno dunque inizialmente una connotazione a carattere turistico (alberghi, fiere, mostre), incluse le risorse culturali (musei, congressi). Nasce così il circuito City Net.
Mentre le esperienze del primo e secondo tipo assumono comunicazione bidirezionale e utenti attivi come loro tratti caratterizzanti, la terza prevede in genere livelli di interattività più bassi. Inoltre le prime due sono fortemente indirizzate ai membri di una comunità locale, mentre le ultime offrono informazioni e servizi utili soprattutto ai non-residenti. Per questa ragione appare improprio usare il termine "rete civica" per iniziative che si limitano a pubblicare sul Web informazioni su una data città, senza prevedere alcun ruolo attivo da parte dei cittadini.
Queste tre tipologie di reti "centrate" intorno ad una città, o in una ben definita area geografica, non sono in effetti in alternativa reciproca, ma si possono, e forse devono, proficuamente integrare ed estendere.
Integrarsi perché si completano a vicenda e hanno l'una bisogno dell'altra. A cosa servono gli sforzi e gli investimenti di una Amministrazione per sviluppare servizi "on line" se poi questi sono scarsamente utilizzati dai cittadini? Ma questi difficilmente trovano stimolante, forse perché troppo simile ad altri media, un ambiente (ancora una volta) costruito e gestito da chi amministra la città, senza (o con ridottissime) possibilità, per i cittadini, di immettere essi stessi notizie, di proporre spazi autonomi di discussione, che sovente divengono luoghi di socializzazione (che dal virtuale si sposta al reale, dall'incontro in rete a quelle "de visu"), aggregazione per affinità e interessi condivisi (e che potrebbero essere, per politici accorti, occasioni preziose per "ascoltare" - discreti - la città).
Estendersi ad integrare anche la componente "business", superando l'approccio "politically correct" delle esperienze nord americane. Una opportunità dovuta alla minor forza delle reti commerciali, ma anche un'esigenza se si tiene conto che il tessuto produttivo del nostro Paese non è fatto (solo) dai grandi gruppi, ma dalla miriade di piccole e medie imprese, da artigiani e professionisti che finora sono rimasti estranei da esperienze di innovazione derivanti dal networking e dal groupware.
Ed in effetti, a ben guardare, non è molto diverso l'utilizzo della rete, specie se su scala locale, per un'associazione, un Ente Pubblico o un'impresa privata, perchè tutte possono usarla per:
a) farsi conoscere, diffondendo informazioni su prodotti e servizi; disporre di una ricca base di informazioni on-line è infatti utile, perchè lo strumento telematico fornisce, come valore aggiunto rispetto ad altri canali distributivi maggiori possibilità di ricerca (non solo per parole-chiave predefinite, ma anche con più sofisticate tecniche di trattamento del linguaggio naturale) e di riuso (l'informazione trovata può essere utilizzata nel contesto di un attività che si sta svolgendo).
b) interagire con i cittadini, cioè con la propria "clientela", usando in genere una forma di dialogo non strutturato, che sia aperto a suggerimenti e lamentele, proposte e critiche;
c) offrire servizi interattivi, il che in genere implica l'utilizzo di schemi di dialogo in tutto o in parte predefiniti e l'integrazione con i procedimenti ed il sistema informativo dell'Ente.
Il benessere e la sopravvivenza della rete civica, intesa come essere punto d'incontro e strumento per la città nel suo insieme, cioè per tutte le componenti di una comunità locale, risulterà allora dall'armonico equilibrio di tre dimensioni che possiamo così caratterizzare:
- la free net, cioè la rete che garantisce ai cittadini, gratuitamente (o comunque a bassissimo costo) accesso e servizi minimi (almeno, una casella di posta elettronica indirizzabile da Internet)e spazi autonomamente definibili di discussione;
- la civic&commerce net, cioè la rete in cui enti pubblici e privati, associazioni e organizzazioni mettono a disposizione dei cittadini servizi informativi, interattivi e si rendono disponibili al dialogo con la cittadinanza;
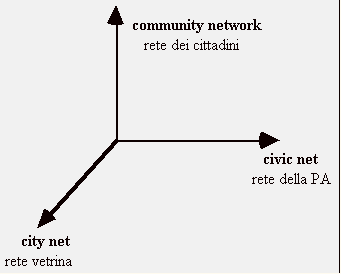
Figura 1.1: Le tre dimensioni di una Rete Civica
Alla luce di ciò, proponiamo una definizione di rete civica, che superi l'ambiguità del termine italiano, chiarendo cosa la caratterizza e differenzia rispetto ad altre iniziative telematiche e sistemi di rete.
1.5 Definizione e caratterizzazione di Rete Civica.5 Definizione e caratterizzazione di Rete Civica;
Una Rete Civica è un ambiente telematico che si propone di promuovere e favorire la comunicazione, la cooperazione e l'erogazione di servizi fra i cittadini e tutti i soggetti (Associazioni, Enti Pubblici, Aziende) che costituiscono una comunità locale e, al tempo stesso, aprire la comunità locale alla comunicazione via rete con il resto del mondo e così garantire a tutti il diritto di cittadinanza telematica.
Una Rete Civica si caratterizza dunque rispetto ad altre iniziative telematiche e sistemi in rete per i seguenti elementi:
1. contenuto fornito dagli aderenti;
al di là degli information provider istituzionali o privati, ciascuno ha il diritto/dovere di contribuire alla base informativa condivisa dalla comunità;
2. comunicazione non solo broadcast ma bidirezionale;
disporre di una ricca base di informazioni on-line è utile, ma altrettanto e forse ancor più importante è che sia possibile interagire, individualmente o - meglio ancora - collettivamente con chi quell'informazione ha reso disponibile: in questo modo la comunità on-line ha la possibilità di dare feed-back su utilità, aggiornamento, completezza, tempestività dell'informazione, nonché avanzare suggerimenti e proposte che da essa possono scaturire; in tal modo si evita inoltre di ridurre la telematica ad un ulteriore media a fruizione passiva;
3. facilità d'uso e/o iniziative di supporto a carattere formativo per garantire l'effettivo accesso a chiunque;
il diritto di cittadinanza telematica è garantito se la tecnologia è così facile da usare che non costituisce una barriera di accesso per la maggior parte della popolazione o se comunque vengono messi in atto programmi di formazione che la raggiungano;
4. economicità;
il diritto di cittadinanza telematica è garantito se la tecnologia prescelta consente il collegamento con hardware (personal computer e modem) poco costoso e software gratuito o se viene garantita la disponibilità di un numero adeguato di postazioni pubbliche di accesso alla rete civica;
5. condivisione di regole di "buon comportamento telematico" (o netiquette);
una rete civica non può non salvaguardare il diritto di tutti ad "essere in rete", con particolare attenzione a fasce specifiche, tipicamente più deboli, della popolazione a cominciare dai più giovani, a cui bisogna garantire un ambiente di comunicazione ispirato alle regole della convivenza civile; particolare attenzione meritano gruppi sociali quali carcerati, portatori di handicap o di malattie, per il fatto che proprio tali soggetti possono trarre grande vantaggio dalla comunicazione "a distanza" propria della rete;
6. non anonimato (se non in casi ed aree specifiche);
proprio dall'affermazione del diritto di cittadinanza telematica scaturisce il diritto/dovere di riconoscimento reciproco: ciascuno ha infatti il diritto di ri-conoscere nel proprio corrispondente via rete il proprio vicino di casa, il proprio compagno di scuola, il proprio collega di lavoro e nessuno può nascondersi dietro pseudonimi, se non in ambiti e per ragioni richieste dalla tutela di segmenti di popolazione particolari (più sopra indicati).
Vogliamo sottolineare che i 6 principi qui sopra elencati possono essere visti come i requisiti minimi che caratterizzano una rete civica. Se taluni possono essere non compiutamente realizzati al momento dell'avvio, è bene averli fin dall'inizio del progetto presenti per partire "con il piede giusto": alcune scelte iniziali che vanno in senso diverso, possono essere difficili da recuperare in seguito. Il capitolo 2 è interamente dedicato alla spiegazione delle scelte da effettuare, sia sul piano tecnologico che su quello di organizzazione della comunità telematica, affinché una nascente rete possa agevolmente assumere le caratteristiche sopra esposte.
Si tratta in altre parole di aver chiaro da subito che lo sviluppo di una rete civica è un percorso, un processo, che, si propone di considerare e massimizzare tutte e tre le dimensioni sopradette in modo equilibrato.
Il punto di partenza sarà ovviamente diverso in funzione di chi ne è il promotore. Diverso è infatti se a prendere l'iniziativa è una Università (Milano) o un gruppo di cittadini (San Donato, Varese) che si costituiscono in associazione, anche con una funzione di stimolo nei confronti di amministrazioni arretrate o disattente, da quando è invece l'ente pubblico locale - tipicamente il Comune (Bologna, Desenzano), ma può essere anche la Provincia (Sondrio) o la Comunità Montana; o infine l'iniziativa può anche venire da privati, come è stato ad esempio a Bergamo (Rete Civica della Bergamasca).
Ciò che conta, se si vuole costruire una rete civica che si propone di coinvolgere tutte le componenti della comunità, è che chiunque faccia il primo passo, faccia anche ogni sforzo perchè sia chiaro che lo spazio creato è aperto a tutti, anche ai non "fondatori", sforzo più facile a dirsi che a farsi in un momento come questo ed in un Paese come il nostro in cui ciò che distingue (religione, colore della pelle, colore politico) diventa elemento di divisione e contrapposizione, in cui da un positivo senso di appartenenza ad una comunità si è passati a dare cittadinanza solo a coloro che "appartengono" a qualche cordata/partito/clan più o meno legittimo, in cui, in questi ultimi anni, anche l'iniziativa privata, è finalizzata, targata e "colorata".
Una cosa però va detta, e una discriminante messa: e cioè che è improprio usare il termine rete civica per iniziative che non prevedono un ruolo attivo dei cittadini nello sviluppo della rete stessa. Scriveva J.J. Rousseau in Du Contract Social: <Les maisons font la ville, mais les citoyens font la cité>. Duecento anni dopo, nell'epoca della cittadinanza telematica, le cose non sono cambiate: senza cittadini non c'è città, ma "essere cittadini" vuol dire poter contare, costruire e progettare, esprimere opinioni ed idee, non solo leggere e, timidamente, fare domande.
Questa discriminante nulla toglie a realizzazioni diverse. Ve ne sono alcune, validissime e di grande utilità e successo, che si propongono di fornire servizi on line ai cittadini. Primo di tali esempi è stato il Servizio Telematico Pubblico della città di Torino avviato nel luglio 1995 dalla prima Giunta Castellani e guidato da Giovanni Ferrero, il quale, scelse di fare un grande sforzo di innovazione all'interno del Comune e iniziare, a partire dai settori più avanzati, quali quello cartografico, a fornire servizi on line ai cittadini, come individui, o nella loro dimensionale professionale. Pur avendo adottato alcune misure di incentivo alla telematica di massa, il coinvolgimento attivo dei cittadini veniva consapevolmente demandato ad un momento successivo; conseguente e coerente con tali scelte progettuali, venne adottato un nome - Servizio Telematico Pubblico - che non generava confusione.
Diverso è il caso di quando vengono realizzate pagine web che danno informazioni di vario tipo su una data città, a volte per iniziativa del Comune, ma talvolta anche per iniziativa di privati che vogliono così attrarre visitatori. Si tratta sovente di siti puramente illustrativo/informativi per i quali sarebbe più opportuno usare il termine di city web (o altro equivalente). E l'attivazione di qualche gruppo di discussione su temi di interesse locale basta giusto ..... a mettere a posto la coscienza.
Il punto qualificante è comunque se i cittadini possono utilizzare (appunto da utenti ) spazi messi a disposizione da chi gestisce il sistema, o se invece possono contribuire al suo sviluppo. In sintesi: la rete civica è sì uno strumento che consente di cooperare, lavorare e (forse) vivere meglio, grazie ai vari servizi (dalla semplice, ma fondamentale, posta elettronica fino a quelli più evoluti come la possibilità di effettuare pagamenti e gestire pratiche complesse) messi a disposizione a domicilio, e possibilmente tramite postazioni pubbliche. Ma essa non può essere ridotta nè alla diffusione via rete di informazioni e avvenimenti cittadini nè a puro terminale domestico dei sistemi informativi comunali (pur se integrati con quelli di altri enti), mero servizio, come l'acqua e il gas, senza partecipazione e dialogo. La rete civica, nel suo senso pieno e compiuto, valorizza il contributo attivo di tutte le componenti della comunità locale.
1.6 Reti Civiche, servizio universale e rapporto con gli Internet Providers.6 Reti Civiche, servizio universale e rapporto con gli Internet Providers;
All'inizio dello sviluppo delle reti civiche italiane (estate 1994) si è assistito ad una sorta di contrapposizione (tipicamente tra Rete Civica di Milano e Iperbole di Bologna) che includeva, ma confondeva, due piani molto diversi.
Rcm e Iperbole nascono infatti a brevissima distanza di tempo l'una dall'altra. Il tratto fondamentale che le accomuna, al di là di ciò che le distingue, è la volontà di coniugare (a) partecipazione dei cittadini, (b) servizi innovativi da parte dell'amministrazione pubblica per migliorare la qualità della vita delle persone, e (c) opportunità per tutti - individui, associazioni, professionisti, piccole e medie imprese - di fare esperienza diretta dei nuovi domini di possibilità offerti dalla rete. Ma comune è anche l'idea che un ambiente telematico viene popolato di individui, persone che lo vivono, lo occupano, si incontrano, ci discutono e litigano, lo plasmano e lo modificano, uno spazio inizialmente vuoto, che cresce e cambia, diviene più gradevole o sgradevole. Un mondo virtuale in cui si vedono di continuo i riflessi del mondo reale che lo ha prodotto, ma che a sua volta si riflette su di esso non senza effetti.
Ma questi basilari e comuni obiettivi di fondo, condivisi ben presto da altre iniziative sono stati, agli occhi di molti, oscurati, fino a metterle in contrapposizione, da ciò in cui Rcm ed Iperbole differiscono:
a) Rcm è promossa (come molte free net nord americane) dall'Università, Iperbole dal Comune.
b) Sul piano tecnologico, la contrapposizione è tra una rete realizzata come un sito web e una rete realizzata come BBS: la prima caratterizzata dalla ricchezza grafica di presentazione delle informazioni in forma di documenti HTML, pienamente integrata con la rete Internet, nonchè con una efficiente gestione del sistema informativo comunale, ma penalizzata dalla limitata interattività e dalla difficoltà di produzione e gestione delle pagine dei siti di prima generazione. Le reti tipo BBS d'altro canto si caratterizzano per l'utilizzo del conferencing quale strumento in grado di consentire una interattività generalizzata e una produzione del contenuto alla portata di ogni utente, ma risentono dell'utilizzo di software e di protocolli di comunicazione non standard (cioè diversi da quelli di Internet) nonché della minore efficacia divulgativa dei messaggi rispetto a quella delle pagine Web.
c) Sul piano politico-sociale vi era una diversa valutazione del ruolo della Pubblica Amministrazione, rispetto a quello dei privati, nella promozione della telematica e, di conseguenza, una diversa scelta nel dare attuazione al diritto di cittadinanza telematica che tanto Iperbole che Rcm intendono da sempre garantire: ritenere preponderante il ruolo dell'ente pubblico ha portato Iperbole a fornire connessione "full Internet" a tutti gratuitamente e con sconti significativi alle piccole e medie imprese dell'area metropolitana (nell'ambito di una convenzione sottoscritta con il CINECA, provider della connettività). Una diversa valutazione porta invece Rcm a considerare la sola E-mail Internet come "servizio universale" da garantire gratuitamente a tutti grazie al supporto offerto dal provider, in questo caso I.Net.
Riguardo al primo punto, si è già detto più sopra. Riguardo al terzo, non è questa la sede per valutazioni a forte valenza economico-politica che possono anche mutare con l'andar dl tempo: va solo detto che a tre anni di distanza Rcm è (ancora) rimasta gratuita, mentre Iperbole dal 1998 ha introdotto una tariffa di accesso (ad un prezzo comunque significativamente inferiore a quello di mercato).
Al secondo punto riteniamo invece necessario dedicare maggiore attenzione, ed è infatti ad esso che è dedicato il prossimo capitolo.
Capitolo 2
Architettura tecnologica e organizzazione sociale nel progetto di una rete civica
Tra le prime scelte che si trova davanti chi vuole avviare una rete civica c'è quella architettura, che spesso molto concretamente significa dar risposta alla domanda: BBS o Internet ? E, nel caso si opti per la BBS, quale software scegliere ?
Storicamente le Free Nets americane sono nate come BBS, utilizzando in genere un software sviluppato alla Case Western University di Cleveland, detto Free Port, che ha una interfaccia a caratteri: nonostante ciò Free Port è ancora ampiamente utilizzato. Tuttavia, il diffondersi del World Wide Web ha imposto anche alle reti civiche di confrontarsi con questo standard di condivisione di informazioni su scala mondiale. Alcune, a partire dalla Free Net di Boulder (Colorado) l'hanno scelto come propria piattaforma; altre, come la Prairie Net di Urbana Champaign [PNUC], hanno adottato un'architettura mista, BBS e WEB.
In questo capitolo, cerchiamo di dare gli elementi per una scelta consapevole e di motivare infine quello che costituisce una sorta di "consiglio". Dapprima, però, viene svolta una puntuale analisi delle funzionalità che sono necessarie per realizzare una rete civica che voglia soddisfare i requisiti minimi fissati in §1.5.
Non possiamo qui prescindere da una trattazione più tecnica che altrove (né possiamo, per ragioni di spazio e tempo, spiegare i termini tecnici che usiamo: in Appendice, tuttavia abbiamo inserito un breve glossario); ma speriamo che, al di là di questi punti (che invitiamo il lettore non esperto a saltare a pie' pari) le conclusioni a cui si giunge siano intellegibili.
2.1 Architettura di una rete civica.1 Architettura di una rete civica;
Nel corso degli ultimi anni, le tecnologie di rete sono profondamente cambiate, influenzandosi e migliorandosi a vicenda.
Da una parte, la tecnologia Web, che inizialmente penalizzava fortemente l'interattività, si è rapidamente evoluta grazie a strumenti quali i form HTML, i linguaggi Java e Javascript, i cookies, ecc. che consentono la realizzazione di applicazioni CGI in grado di migliorare enormemente l'interazione tra l'utente e il sistema. Non solo, il mondo del software di gestione dei siti Internet sta anch'esso evolvendo verso la fornitura di funzionalità tipiche del groupware quali scheduling dei gruppi di lavoro, workflow, condivisione di documenti, ecc.
D'altra parte, i sistemi proprietari - sia i sistemi di posta elettronica che i sistemi di groupware quali MS Exchange, GroupWise, Lotus Notes, FirstClass, ecc. - si stanno sviluppando in modo da incorporare i protocolli standard di Internet, al fine, ad esempio, di consentire il reperimento di documenti tramite HTTP o lo scambio di posta via SMTP.
Alla luce di queste considerazioni è possibile delineare per una rete civica una architettura che prescinda dalla piattaforma software sulla quale è implementata e che sia invece fondata sulle scelte di disegno concettuale. La distinzione non è più quindi tra rete civica tipo BBS o sito Web, in quanto i termini della scelta si collocano ad un livello superiore.
Le caratteristiche esposte nel paragrafo precedente, che caratterizzano una rete civica rispetto ad altre reti telematiche, possono infatti essere viste come una sorta di requisiti del sistema che si concretizzano in una serie di funzionalità, a loro volta realizzate grazie ad un insieme di tecnologie e strumenti. Queste ultime sono elencate in Tabella 1, unitamente al requisito che concorrono a realizzare.
|
Requisiti di sistema |
Funzionalità (tecnologie e strumenti) |
|
Economicità di accesso localmente |
Accesso via modem |
|
Facilità di accesso ed economicità (globalmente) |
Accesso via Internet |
|
Servizi interattivi di consultazione di banche dati |
Accesso a database |
|
Apertura verso altre reti |
Collegamenti con altre reti o server |
|
Apertura della comunità locale alla comunicazione via rete con il resto del mondo |
E-mail Internet |
|
Broadcasting su larga scala e in modalità standard |
Aree informative |
|
Interattività, contenuto fornito dagli utenti, base comunitaria |
Aree di discussione (conferencing) |
Tabella 1: Requisiti di sistema e funzionalità
Nel seguito discutiamo brevemente ciascuna delle coppie requisito-funzionalità.
2.1.1 Accesso via modem e via Internet.1.1 Accesso via modem e via Internet;
Entrambi questi tipi di accesso sono indispensabili per realizzare il requisito dell'economicità. Consentendo l'accesso via modem si mette in grado l'utente di accedere alla rete al solo costo della chiamata telefonica senza la necessità di un abbonamento ad Internet. D'altra parte a causa dell'attuale criterio di tariffazione telefonica può essere conveniente per chi sarebbe, per varie ragioni, costretto a collegarsi in teleselezione, scegliere invece l'accesso via Internet tramite un provider locale.
2.1.2 Accesso a database.1.2 Accesso a database;
Una delle possibilità che le reti offrono è di rendere disponibili ad un vasto "pubblico" informazioni già raccolte in archivi elettronici. E' in quest'ottica che una rete civica dovrebbe essere in grado di interfacciare, in modo diretto o indiretto (cioè mediato da operatori), i database che i soggetti pubblici e privati connessi in rete possono (e/o vogliono) mettere a disposizione del pubblico, quali, ad esempio, i cataloghi delle biblioteche, o gli atti pubblici (leggi, delibere, piani regolatori, documenti catastali, ecc.), contenuti negli archivi degli Enti competenti.
2.1.3 Collegamenti con altre reti o server.1.3 Collegamenti con altre reti o server;
Chiunque oggi decida di mettere in piedi un proprio server di rete è bene tenga presente che si troverà ad operare in un settore in cui moltissimi sono già le strutture e i soggetti presenti: Internet, le reti civiche, le reti di comunicazione amatoriali, reti e/o server della Pubblica Amministrazione, di Enti pubblici e privati, di aziende anche di grosse dimensioni, ecc. In tale scenario occorre creare un ambiente potenzialmente aperto all'interazione con il più alto numero possibile di sistemi. Nei sistemi proprietari di comunicazione tale apertura si realizza con la possibilità di realizzare gateway cioè procedure che periodicamente effettuano la conversione e lo scambio dei dati dal formato proprio del sistema a quello di un sistema esterno oppure da quello proprio ad uno standard noto ad entrambi.
2.1.4 E-mail Internet.1.4 E-mail Internet;
Si è già detto che l'E-mail Internet - cioè la possbilità per chi si registra alla rete civica di avere gratuitamente un proprio indirizzzo Internet (del tipo: nome.cognome@rc.sito.it) da cui mandare e su cui riceve posta elettronica con il resto del monso - costituisce il minimo comune denominatore della comunicazione bidirezionale in Internet. Allo stadio attuale di sviluppo della telematica riteniamo che questo sia il servizio universale che garantisce quel diritto di cittadinanza telematica che le reti civiche si propongono di fornire. Esso costituisce anche il "punto di ingresso" (hook) verso l'utilizzo di tecnologie di rete più avanzate, da acquisire da parte di ciascuno, sul libero mercato.
2.1.5 Aree informative.1.5 Aree informative;
La diffusione di informazioni in maniera efficace, cioè facilmente accessibile e reperibile (searching) è una condizione chiave per il successo di una rete civica. Le pagine Web hanno il pregio di riunire in un unico documento informazioni in forma testuale, grafica, sonora, ecc., e di essere collegate tra loro in forma ipertestuale. Ciò realizza, almeno in parte, i requisiti di efficacia suddetti, tanto da aver decretato il successo del Web, e con esso di Internet, come standard mondiale e rende sempre più indispensabile l'utilizzo di questo strumento per le funzionalità di broadcasting della rete civica. Da un punto di vista tecnico la pubblicazione di informazioni su Web può essere realizzata sia attraverso un server standard che attraverso un server di BBS/groupware che supporti il protocollo HTTP per la diffusione delle informazioni in esso residenti (ad esempio, FirstClass Intranet Server o Lotus Notes/Domino).
2.1.6 Aree di discussione.1.6 Aree di discussione;
Il conferencing è una forma di discussione di gruppo e realizza quindi un tipo di comunicazione molti a molti; ogni conferenza è caratterizzata da un tema più o meno ampio, cioè un argomento sul quale vertono i messaggi in essa contenuti, organizzati in thread. Pur essendo una forma di comunicazione molto simile a quella delle mailing list, queste ultime risultano meno adatte a supportare molteplici discussioni simultaneamente: le e-mail infatti pervengono tutte indistintamente in mailbox con un devastante effetto invasivo. Risultano inoltre più ostiche da gestire per un'utenza non necessariamente esperta quale quella delle reti civiche. Le conferenze possono essere pubbliche o private (aperte a tutti o riservate ad utenti con specifiche caratteristiche), moderate o non moderate (i messaggi sono leggibili a tutti previa approvazione di un responsabile oppure appena giungono in conferenza) e solitamente consentono la differenziazione dei livelli di accesso in modo che alcuni partecipanti abbiano, ad esempio, permesso di sola lettura, o di lettura e scrittura, oppure nessun accesso. Un utente dovrebbe poter eseguire ricerche sui messaggi ad esempio per mittente o per parole chiave, sia nel subject che nel corpo del messaggio. Il conferencing deve infine essere capace di replicazione. Esistono due tipi di replicazione: quella server-to-server e quella server-to-client; la prima consente di spostare i dati nei luoghi dove gli utenti ne fanno richiesta ed assicurarne la disponibilità eliminando la dipendenza da un singolo server; la seconda consente una modalità di lavoro off-line a tutto vantaggio dell'economicità del sistema.
Entrambe le possibili architetture con cui una rete civica può essere costituita, consentono di mettere a disposizione la funzionalità di conferencing. Nell'architettura BBS le caratteristiche di tale funzionalità dipendono dal software adottato per la gestione della BBS stessa; i più importanti offrono tutte le funzionalità brevemente descritte sopra in versioni più o meno sofisticate. Nell'architettura su sito Internet o intranet il conferencing può essere realizzato utilizzando un server NNTP o affiancando il server Web con un sistema di conferencing web-based (cioè un sistema che usi browser e server Web per fornire la maggior parte delle sue funzionalità) fra i numerosi esistenti. Sia nell'uno che nell'altro caso quindi il solo server web non è sufficiente per fornire questa funzionalità e ciò si traduce in un sovraccarico nella gestione dell'intero sistema. Entrambe le tecnologie offrono vantaggi e svantaggi: NNTP è un protocollo non stateless (a differenza dell'HTTP) e quindi la comunicazione può risentirne se la connessione non è veloce; non tutti i newsreader possiedono tutte le funzionalità che sarebbero auspicabili (ma la situazione è in rapida evoluzione); i server non sono dotati di tools per la gestione e riorganizzazione delle directory (anche in questo caso però ci sono segnali di rapida evoluzione). I vantaggi dell'NNTP sono principalmente l'interfaccia utente più sofisticata e rispondente in termini di prestazioni, e la possibilità di gestire entrambi i summenzionati tipi di replicazione di newsgroup.
I sistemi Web-based soffrono della lentezza intrinseca del web dovuta alla navigazione tra le pagine, che risulta ancora più evidente in applicazioni fortemente interattive: solitamente tali sistemi visualizzano i thread di una conferenza in un'unica pagina HTML proprio al fine di ridurre il tempo di caricamento dei messaggi. Un altro collo di bottiglia per le prestazioni di questi sistemi è rappresentato dal fatto che queste sono applicazioni CGI e quindi richiedono spesso l'esecuzione di grosse porzioni di codice interpretato (ad esempio in Perl) o comunque numerosi scambi di dati con il Web server di appoggio (alternativa con prestazioni superiori è quella di utilizzare APIs che consentano alle applicazioni basate su server Web di girare come proprie estensioni). Infine non consentono la replicazione delle conferenze né tra server né tra server e client. Godono però della ipertestualità e della ricchezza grafica delle pagine web nonché della facilità di amministrazione completamente espletabile tramite browser Web e hanno ormai raggiunto un livello di evoluzione tale da essere in grado di offrire tutte le funzionalità brevemente descritte in precedenza (pur con i limiti già citati).
2.2 L'organizzazione sociale della comunità telematica.2 L'organizzazione sociale della comunità telematica;
In questo paragrafo prendiamo in esame l'organizzazione sociale della comunità telematica, cioè le scelte organizzative da effettuare al fine di conferire alla comunità quelle caratteristiche esposte nel §1.4 che non sono strettamente correlate con opzioni tecnologiche (di cui, invece, si è trattato nel paragrafo precedente).
Ai fini di tale descrizione, tre sono le figure che giocano un ruolo fondamentale:
- l'aderente attivo e identificabile, contrapposto all'utente passivo eventualmente anonimo, considerato basilare rispetto alla costruzione di una comunità telematica che voglia definirsi Rete Civica;
- i moderatori di conferenze, cioè coloro che tra gli aderenti assumono il ruolo fondamentale di promotori e gestori di singole discussioni;
- lo staff, cioè l'insieme degli Amministratori di sistema, dei responsabili di progetto e dei loro collaboratori, che si occupano della gestione della rete in senso stretto.
2.2.1 L'identificazione degli utenti in Internet e nelle reti civiche.2.1 L'identificazione degli utenti in Internet e nelle reti civiche;
Cominciamo facendo un passo indietro e ritornando ad Internet come modello ispiratore per quel che riguarda non solo le funzionalità di base a supporto di una comunità in rete (posta elettronica, condivisione dei documenti e forum di discussione), ma soprattutto per aver mostrato come le comunità possano trarre beneficio dalla telematica. Ma Internet non è in sè una singola rete, bensì una "rete di reti", e proprio perché costituita di tante reti locali, ciascuna delle quali ha in carico la scelta della politica di riconoscimento degli utenti da adottare, non esiste la possibilità di garantire l'identità di ogni singolo membro della rete.
Se guardiamo alle comunità che su Internet si sono appoggiate ed evolute, quali ad esempio le comunità di ricercatori legati dallo stesso campo di ricerca, vediamo che queste si basano su elementi di fiducia, reputazione dei singoli membri, aspetti di reciprocità, che sono possibili quando i contributi di ognuno sono "certificabili". Tuttavia questa motivazione rimane ancora per lo più intuitiva, poiché non sono ancora molti i lavori di ricerca a nostra conoscenza, che illustrino l'importanza degli elementi di riconoscibilità nella cooperazione in rete. Tuttavia alcune importanti osservazioni in questo senso sono riscontrabili nel campo di applicazione dei servizi pubblici. Si osserva che conoscere con nome e cognome il funzionario e il pubblico amministratore rende il servizio erogato, non solo conforme alla legge 241 sulla trasparenza amministrativa, ma favorisce l'utente e il pubblico funzionario a sentirsi partecipi dello stesso processo: anche comunicazioni del tipo "non aggiorno le informazioni per un mese perché vado in ferie" vengono accettate molto più facilmente dagli utenti [...] che non messaggi del tipo "il servizio non sarà attivo per un mese causa ferie". L'identificazione in rete costituisce il prerequisito perché l'erogazione di servizi complessi sia un processo comunicativo creante valore, andando così oltre la visione dei servizi telematici quale mera automazione del front-office, ed arrivare alla personalizzazione evidenziata come un parametro di qualità rilevante agli occhi del cittadino. In questo caso netta è la distinzione rispetto a quelle esperienze (Modena, Torino) in cui la rete rimane essenzialmente una civic net, in cui l'identità di chi invia un messaggio ad un politico (tipicamente il Sindaco e gli Assessori), ad un funzionario o più spesso ad un ufficio è inserita al momento dell'invio del messaggio (per cui io posso inviare una mail di questo tipo dalla login di un mio parente od amico) e non è verificata dal gestore della rete. In questo caso l'attenzione è posta verso una generica possibilità di comunicazione, ma non è prestata attenzione sufficiente perché si crei un vero rapporto di comunicazione fra l'erogatore e il fruitore del servizio che possa svilupparsi nel tempo.
E' importante evidenziare che l'anonimato non è ritenuto negativo in sè, ma solamente meno adatto alla creazione di una comunità telematica basata su principi di fiducia e conoscenza reciproca degli interlocutori. Nell'esperienza della Rete Civica di Milano, l'approccio all'anonimato è di renderlo disponibile ogni qualvolta sia utile per proteggere membri della comunità che per motivi vari potrebbero subire discriminazioni. L'anonimato diviene in questi casi un mezzo per rinsaldare la comunità, per allargarne i contorni permettendo a chiunque di esprimersi. Ciò è ben esemplificato dalla conference "Omosessualità e Società", che fornisce la possibilità di inviare messaggi firmati da pseudonimi, lasciando ai moderatori la responsabilità di mantenere la discussione nell'ambito dei temi della conferenza.
Strumenti in grado di caratterizzare i membri della comunità, come l'identificazione certificata dagli amministratori associata alla compilazione di un profilo personale e professionale, permettono di vivere la vita telematica non come luogo alieno, ma come parte di un continuum dove i membri della comunità reale possono continuare ed estendere la condivisione di esperienze. Ed in questo contesto "le feste" e comunque gli incontri organizzati via rete (esempi ce ne sono nelle esperienze di Milano, Desenzano e Bologna) vanno viste come parte integrante di un progetto di rete civica per rinsaldare la comunità.
2.2.2 Da utenti a progettisti di servizi.2.2 Da utenti a progettisti di servizi;
Un ambiente dove i soggetti siano in grado di "riconoscersi", perché hanno gli strumenti per capire le affinità di interessi e dove viene data importanza alla assunzione di resposabilità, sia essa del cittadino o del funzionario pubblico o del responsabile di un servizio commerciale, è il presupposto di una Rete Civica costituita da aderenti attivi, piuttosto che da utenti passivi. Sulla base di questa nozione di assunzione di responsabilità, il primo passo verso l'attivizzazione è la possibilità da parte degli utenti di proporre aree di discussione dal basso (scelta iniziale di Rcm mutuata poi da numerose altre esperienze anche a parziale correzione di un iniziale progetto che prevedeva le aree di discussione definite dai gestori della rete) e progettare servizi. Un esempio di servizio disegnato "dal basso" a partire dalle concrete esigenze, è l'esperienza "Feltry on line" di RCM. "Feltry on line" è un esperienza di teledidattica, per assicurare la continuità didattica, anche agli studenti forzatamente a casa per motivi di salute. Totalmente pensato dai membri della struttura scolastica, ha trovato nella Rete Civica il partner in grado di fornire la competenza tecnologica necessaria, nonché una struttura predisposta a fornire servizi alla comunità (si pensi che tutti gli altri studenti eventualmente già presenti su RCM possono così comunicare con lo studente rimasto a casa, mentre soluzioni ad hoc al di fuori di una struttura comunitaria renderebbero ciò più complesso).
Una rete di aderenti attivi così delineata, si pone come una struttura intermedia, né completamente anarchica, come può essere considerata per certi aspetti Internet, né completamente centralizzata, con servizi forniti ed erogati "dall'alto" dalle varie entità, istituzionali e commerciali. E' una rete mediata, in grado di auto-regolamentarsi pur rimanendo aperta nel suo sviluppo.
2.2.3 I moderatori.2.3 I moderatori;
Figura centrale nella costituzione di un tale tipo di rete, nonché gradino immediatamente successivo nell'impegno di un aderente in rete, è il moderatore, cioè colui che volontariamente si assume la gestione e la cura di un'area di discussione, su delega dello staff. I compiti principali che un moderatore dovrebbe svolgere al fine di rendere la conferenza utile, fruibile e ricca di spunti, sono, in base alla nostra esperienza, i seguenti:
1) approvare (cioè rendere leggibili a tutti gli aderenti) i messaggi inviati in conferenza. L'approvazione di un messaggio richiede da parte di quest'ultimo il rispetto dei principi e del galateo della rete e del tema della conferenza. A questo proposito è indispensabile definirne e circoscriverne con cura l'argomento: un tema troppo generico equivale ad una moderazione difficile, diventando molto soggettivo il giudizio sui messaggi fuori tema;
2) monitorare, incentivare e promuovere la conferenza: questo significa mantenere la conferenza facilmente fruibile (archiviando i messaggi più significativi e cancellando quelli divenuti inutili), "avere il polso" della stessa, e, se necessario, fare in modo di rivitalizzarla con nuovi spunti, o eventualmente considerare l'opportunità di sospenderla o chiuderla (non è detto che una conferenza debba durare per sempre).
3) collaborare con l'amministratore in tutte le sue azioni volte a migliorare la fruibilità della conferenza, a conoscerne l'andamento o ad evitarne la decadenza (ad esempio, segnalare situazioni che possono generare liti in rete - flames - prima che degenerino danneggiando la conferenza);
4) automoderarsi: il moderatore deve preventivamente chiedersi se ogni suo messaggio soddisfa i requisiti che richiede per approvare i messaggi altrui.
Moderare non significa quindi censurare l'altrui pensiero, ma svolgere un servizio di educazione alla comunicazione telematica. Al crescere della rete, inoltre, la pertinenza dei messaggi alla conferenza è fondamentale per non perdersi nel mare magnum delle aree informative e di discussione. In caso di non approvazione di un messaggio il moderatore deve sempre darne motivazione scritta al mittente, cercando di far comprendere i motivi di tale atto e invitando a rispedire il messaggio opportunamente sistemato.
2.2.4 La condivisione di regole di "buon comportamento telematico".2.4 La condivisione di regole di "buon comportamento telematico"1 ;
Come tutte le comunità umane anche la comunità telematica di una rete civica necessita di regole di comportamento atte a garantire il corretto andamento dell'attività in rete; fatte salve le norme dello stato di diritto, tali regole attengono esclusivamente alle specificità del mezzo telematico. Al fine di garantirne il rispetto è necessario:
- farle conoscere al momento in cui una persona entra in rete la prima volta (accettazione dei "Principi e del Galateo della rete" come passo fondamentale della procedura di registrazione in rete;
- garantire che nessun messaggio pubblico o privato immesso in rete le violi; questo viene fatto, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, con l'ausilio dei moderatori, che con la loro azione volontaria sottopongono ciascun messaggio ad una verifica di conformità al Galateo.
Data l'importanza che assumono nella vita della rete e la delicatezza del loro ruolo, può essere conveniente predisporre una sorta di "galateo dei moderatori", cioè un documento sottoscritto dagli stessi, che ne definisca in maniera precisa i compiti, al fine di responsabilizzarli e renderli maggiormente consapevoli di ciò che ci si aspetta da loro.
Anche a fronte della necessità di tenere conto di alcune recenti disposizioni di legge, nonché sulla base delle esperienze fatte e delle considerazioni su esposte, A.I.Re.C. sta predisponendo per i suoi soci, uno schema di Galateo che precisi ruoli e responsabilità di aderenti, moderatori e amministratori della rete.
Capitolo 3
Possibili implementazioni
Dalle considerazioni svolte nel capitolo 2 riguardo ai requisiti che una rete civica deve soddisfare e alla loro realizzazione tramite le funzionalità disponibili sulle diverse piattaforme software, possiamo sintetizzare l'architettura di una rete civica come in Figura 3.1.
Fig. 3.1 : L’architettura di una rete civica
3.1 Possibili implementazioni di una rete civica .1 Possibili implementazioni di una rete civica ;
Dalla Figura 3.1 emerge la possibilità di utilizzare tanto un server di intranet accoppiato ad un server "full Internet", quanto un server tipo BBS/groupware collegato ad un server Web. In Figura 3.1 abbiamo indicato con il termine generico "community server" il server di BBS o di intranet per indicare che in esso sono implementate preferibilmente la funzionalità di conferencing, groupware e gestione degli accessi/accounts degli utenti. Il sistema risulta tanto più efficace nell'assolvere alle sue funzioni quanto più i due server sono integrati tra loro; proprio per rispondere a questa esigenza di integrazione i server di BBS/groupware si sono evoluti per incorporare e gestire i protocolli standard di Internet in aggiunta ai loro protocolli proprietari. Tuttavia, da un punto di vista logico-funzionale, la distinzione permane e quindi chiameremo ugualmente un'architettura di questo tipo, architettura mista BBS+Web.
Le considerazioni svolte nel § 2.2.2 mettono l'accento sul ruolo degli utenti nello sviluppo di una rete civica al fine di valorizzare le possibilità di interattività proprie della telematica (che non la sviliscano ad un nuovo medium di tipo broadcast), per lo sviluppo della comunità locale, vista non come mero fruitore di servizi telematici erogati da Enti pubblici e privati, ma come risorsa per lo sviluppo (si veda a tale proposito l'evoluzione dell'acronimo CSCW, nato per denotare le tecnologie di Computer Supported Cooperative Work, che viene oggi usato per caratterizzare il Computer-Supported Community Work).
Se si conviene sull'importanza di ciò, poiché l'interattività e il dialogo in rete vengono garantiti essenzialmente dalle funzionalità di email e conferencing (partecipazione a gruppi di discussione), alla luce delle considerazioni svolte in 3.1.6, ne segue che, a tutt'oggi, una implementazione dell'architettura mostrata in Figura 3.1 con una piattaforma mista BBS+Web, pare maggiormente soddisfare l'insieme dei requisiti indicati e favorire lo sviluppo della comunità locale.
Essa, inoltre, pare avere ulteriori vantaggi.
1. E' frequente il caso in cui una rete civica sia promossa e gestita da Enti (Pubbliche Amministrazioni locali, associazioni no profit) che non hanno a disposizione né hanno facilità di acquisire le competenze professionali di un "Webmaster" (per di più oggi molto richieste sul mercato). L'architettura mista consente di contenere tali necessità e al limite di eliminarle tramite outsourcing. Proprio le numerose esperienze amatoriali dimostrano che la gestione di una BBS è più alla portata di molti.
2. Optare per un community server realizzato con una Intranet rende il Webmaster un collo di bottiglia nell'inserimento e aggiornamento delle informazioni fornite dagli utenti. Se si pensa a quella "specie" di utenti che sono i funzionari pubblici, il fatto che questi non debbano passare per il collo di bottiglia di un Webmaster (che poi spesso si porta con sé una redazione che da funzioni di organizzazione tende ad assumere rapidamente quelle di controllo), aumenta la probabilità che l'informazione in rete sia mantenuta aggiornata dagli stessi che la producono.
Queste considerazioni saranno presumibilmente annullate dalla evoluzione tecnologica, o viceversa la potranno stimolare; ma ciò nulla toglie al loro valore "hic et nunc". Ed è dunque alla luce di esse che riteniamo oggi ancora preferibile l'architettura mista BBS+Web, a meno che non si dispongano di sufficienti risorse da annullare tali considerazioni. In tal caso l'impianto architetturale di una rete civica è del tutto analogo a quello di una Intranet.
3.2 Configurazione tecnologica minima.3 Configurazione tecnologica minima;
Per attivare una rete civica è necessario acquisire l'hardware, le linee e le connessioni di rete e il software. Queste risorse dipendono ovviamente, in linea di principio, dal bacino di utenza della rete civica stessa, ma nei fatti l'avvio di una rete civica avviene spesso sulla base di una configurazione minima che prescinde dal bacino di utenza (è stata grosso modo la stessa a Milano e Desenzano sul Garda!) e conta sulla cosiddetta "scalabilità" della tecnologia, cioè sulla possibilità di adattarla progressivamente alle crescenti richieste. Questo consente di partire con investimenti ridotti e aumentare l'impegno anche economico dopo una sperimentazione, se questa è convincente.
E' stato comunque valutato che un bacino utile di utenza per la nascita di una Rete Civica potrebbe aggirarsi intorno ai 25.000 abitanti. Per raggiungere tale bacino è anche pensabile che più Comuni, all'interno di uno stesso distretto telefonico, si accordino per la costituzione di una Rete Civica "comprensoriale" che potrebbe favorire l'economia di gestione. Qui di seguito vengono indicate le risorse necessarie all'avvio di una rete civica, distinguendo ciò che è indispensabile da ciò che è opportuno e prescindendo dal software standard di cui è d'uso dotare un computer (pacchetti di word processing, fogli elettronici, database, utilities varie).
3.2.1 Hardware.3.1 Hardware;
E' necessario avere a disposizione:
1. almeno due computer, uno per il server ed uno per l'attività di sviluppo e gestione da parte degli amministratori; ovviamente il computer di sviluppo può essere uno già usato per altre attività, il che di fatto riduce ad uno solo il computer che deve essere dedicato in modo esclusivo alla rete civica;
2. una unità di backup (tipicamente a nastro) per garantire il recupero del servizio in caso di danni di varia natura;
3. una sufficiente dotazione di dischi per la memoria di massa; dare un dimensionamento ottimale della memoria di massa che sarà necessaria per memorizzare le informazioni immesse in rete, è piuttosto complesso, forse impossibile perché dipende dallo sviluppo qualitativo e quantitativo della rete stessa. E' comunque consigliabile partire con almeno un disco fisso di 4 GB e prevedere la possibilità di futuri upgrade del server attraverso l'aggiunta di hard disk esterni (questo comporta per i computer IBM compatibili aggiungere alla configurazione una porta SCSI);
4. un gruppo di continuità che garantisca il corretto spegnimento del server in caso di cadute improvvise della corrente;
5. è inoltre opportuno, laddove possibile, un server di back-up, per ripristinare il sevizio in tempi brevi, in caso di guasto al server principale.
3.2.2 Linee e connessioni.3.2 Linee e connessioni;
E' necessario acquisire:
1. un numero di linee telefoniche in solo ingresso, messe in ricerca automatica (servizio messo a disposizione da Telecom) adeguato al bacino di utenza; anche in questo caso le previsioni sono difficili, ma le esperienze fatte dimostrano che è possibile partire con una base di poche linee (anche solo 2 o 3) in ricerca automatica, da incrementare poi nel tempo. E' inoltre fortemente consigliato, laddove possibile, dotarsi di un'ulteriore linea telefonica (in ingresso e uscita) da riservare a particolari servizi quali i collegamenti con altre reti (gateways).
2. Gli apparati per la connessione delle linee al server. Se il numero di linee è basso (4 o 8) il tipo di connessione "linea - modem - scheda multiseriale inserita nel server" è sicuramente la soluzione più economica e semplice. Al crescere delle linee (oltre le 16) però il carico di lavoro per il server diviene insostenibile; in questo caso la soluzione più opportuna è quella di demandare la gestione delle connessioni ad una macchina dedicata (router) collegata in rete locale al server. I router possono incorporare le schede modem oppure accettare modem esterni in ingresso e possono essere collegati tra loro in modo da consentire l'aumento del numero di linee anche successivamente.
3. Connessione Internet: può variare in funzione dei servizi che si intendono offrire. Se si pensa alla sola Email (oppure Email e Newsgroup) può essere sufficiente un abbonamento ad un provider cui collegarsi tramite una linea di servizio uscente. Se si decide che il server BBS sia raggiungibile da Internet (cf. Figura 3.1), è necessario, acquisire una connessione ad un Internet provider che dovrebbe essere raggiungibile attraverso una linea dedicata o almeno una linea ISDN, con un costo ovviamente superiore.
Capitolo 4
Amministrazione di una rete civica: aspetti critici
Molti dei suggerimenti che seguono discendono piuttosto direttamente dall'esperienza fatta nella gestione della Rete Civica di Milano. Riteniamo comunque che le indicazioni che seguono siano utili da considerare nella gestione di una rete civica.
4.1 Aspetti tecnici.1 Aspetti tecnici;
Una volta installato il server, prima di avviare la rete, è fondamentale decidere:
1. la strategia di backup dei dati della rete e più in generale di sicurezza del sistema;
2. la strategia di distribuzione delle funzioni di amministrazione del server;
3. le varie categorie di utenti e di aree di lavoro e di discussione che costituiranno la rete;
4. la procedura di registrazione degli utenti;
5. la politica di apertura e di organizzazione delle aree di discussione ;
6. la politica di gestione delle singole aree e delle mailbox degli utenti;
7. la politica di rimozione automatica per le varie categorie di messaggi, documenti e utenti;
Per gli approfondimenti dei diversi aspetti evidenziati si rimanda alle specifiche tecniche e alle funzionalità dei software prescelti per l'implementazione dei sistemi.
4.2 Aspetti di gestione degli utenti.2 Aspetti di gestione degli utenti;
Nell'amministrazione di una Rete Civica, bisogna porre una grande attenzione all'aspetto formativo, di introduzione pratica e concreta di chiunque alla telematica, che non è solo imparare a "settare" un modem, a inviare una "e-mail", ma - il che è molto più importante e difficile - è imparare ad usare la rete per "comunicare" con altri esseri umani.
Il comportamento ed il modo di comunicare dell'amministratore sono fondamentali per il successo della rete. La sua presenza deve essere molto discreta ed il suo intervento d'autorità deve limitarsi ai casi estremi di scorretto comportamento telematico; la sua figura è bene che appaia da subito al servizio dei membri della rete che devono sentirlo come un partner fondamentale con cui cooperare per la riuscita di un progetto comune.
La sua opera deve principalmente assicurare una infrastruttura che permetta una comunicazione semplice ed efficace, senza invaderla con la sua presenza, ma rimanendo vigile dietro le quinte.
E' bene che lo sviluppo della rete, sia in termini di aree di discussione che di servizi, sia in buona parte affidato agli utenti/aderenti che vanno costantemente stimolati e "coccolati" in modo da farli diventare co-promotori, co-gestori e co-progettisti della stessa.
Il successo dell'amministratore/i, e quindi della rete, sarà tanto maggiore quanto più sarà/nno stato/i in grado di motivare i vari soggetti in gioco creando un spirito di gruppo ed un caldo clima familiare e cooperativo.
E' assolutamente necessario che ogni account in rete sia individuale, cioè corrisponda ad un unico cittadino con il suo nome, il suo cognome e la sua autopresentazione, in modo da rendere l'ambiente il meno virtuale possibile e da potere, se necessario, individuare puntualmente le responsabilità di ciascuno.
Sono da evitare i flame (pesanti e violenti scontri in rete) in aree pubbliche: se ci sono problemi con i gestori d'area è bene risolverli in privato, pena il forte rischio di distruggere irrimediabilmente le aree stesse rendendo pesante ed invivibile il clima dell'intera rete.
Nel caso in cui i flame pubblici scoppino, il gestore della rete, in stretta collaborazione col/i gestore/i d'area interessata, deve tirar fuori le sue migliori doti di pompiere, evitando assolutamente atti di forza e tentando di far ragionare le parti in causa sdrammatizzando la situazione, ma anche prendendosi la responsabilità di intervenire con decisione quando i tentativi di accordo falliscono.
4.3 Aspetti giuridici.3 Aspetti giuridici;
Gli aspetti giuridici del rapporto che si instaura tra i membri della comunità che si costituisce intorno ad una rete civica sono oggetto di grande attenzione da parte di tutti gli "addetti ai lavori". L'A.I.Re.C. ha deciso quindi di dedicare a questo tema una pubblicazione specifica a cui si rimanda, che tratta i seguenti argomenti:
- alcune questioni giuridiche di rilievo nell'attività delle reti civiche: il diritto alla privacy della corrispondenza, delle transazioni e dei dati personali; la responsabilità del gestore per illeciti commessi dagli utenti e per inefficienza del sistema, la sicurezza informatica, il rispetto del diritto d'autore, la tutela dei consumatori e la propaganda elettorale.
- il Galateo della rete come codice deontologico interno, i ruoli e le relative responsabilità di gestore, moderatore e aderente. Per quanto riguarda i ruoli, vengono indicati due strumenti utili per definire i rapporti tra le tre figure chiave: le condizioni di adesione alla rete civica (responsabilità per i messaggi inviati, dichiarazione della propria identità, ecc.) e il Galateo che individua i principi generali che ne regolano i rapporti.
In cambio del privilegio di aderire alla Rete Civica di Milano, di usare i servizi che offre e di avere accesso alle informazioni in essa contenute, io dichiaro di condividerne i principi ispiratori sopra delineati, di accettare ed attenermi alle norme di comportamento che seguono e a quelle che verranno promulgate periodicamente dagli Amministratori della Rete stessa.
1) L'uso della Rete Civica di Milano (RCM) è un privilegio che può essermi revocato dagli Amministratori della Rete stessa in ogni momento a fronte di un comportamento improprio. Costituisce, tra l'altro, un comportamento improprio: l'immissione nella RCM di informazioni non lecite; lo scambio di software, anche se auto-prodotto, di pubblico dominio o shareware; la pubblicizzazione di prodotti, servizi o altri generi al di fuori dalle aree a questo predisposte ed in particolare nella mailbox di aderenti senza che questi ne abbiamo fatto esplicita richiesta; l'uso di un linguaggio osceno, ingiurioso o che comunque possa essere sgradevole, offensivo e non adatto per altri aderenti, nelle varie aree in cui esso è utilizzato nonché - a seguito di uno specifico esposto - nella comunicazione privata. Gli Amministratori di RCM saranno gli unici arbitri di ciò che ottempera o non ottempera ai criteri suddetti.
2) RCM si riserva il diritto di riesaminare qualsiasi materiale archiviato in un file, accessibile dagli utenti, e commenterà o rimuoverà qualsiasi materiale che giudica a sua pura discrezione improprio, secondo i criteri suddetti.
3) Tutte le informazioni e i servizi presenti in RCM sono disponibili allo scopo di intrattenere e di dare informazioni generali ed intesi per uso privato da parte degli aderenti, ed ogni commercio o uso non autorizzato di questo materiale, in ogni forma, è espressamente proibito.
4) RCM non garantisce che le funzioni del sistema soddisfino specifici requisiti, né che essa sia priva di errori o senza interruzioni. RCM non è responsabile di qualsiasi danno - diretto, accidentale o conseguente (incluso la perdita di dati, informazioni o profitti) - relativo all'utilizzo o all'impossibilità di utilizzo del sistema.
Inoltre dichiaro di sollevare RCM, i suoi responsabili, collaboratori e operatori, e qualsiasi ditta o istituzione con cui RCM è affiliata, per qualsiasi problema, di qualsiasi natura, derivante dal mio uso o incapacità di usare RCM ed il software con cui è realizzata.
B. Documentazione su A.I.Re.C.
A.I.Re.C. - Associazione Informatica e Reti Civiche - Lombardia
Piazza 4 novembre, 5 - 20124 MILANO
Tel. 0255006291
E-mail: airec@dsi.unimi.it - Web: http://wrcm.dsi.unimi.it/airec
Statuto A.I.Re.C.
DENOMINAZIONE - SEDE
Art.1
E’ costituita l’Associazione: "Informatica e Reti Civiche-Lombardia" abbreviata in "A.I.Re.C- Lombardia", con sede in Milano, Piazza 4 Novembre, 5.
FINALITÀ E OBIETTIVI
Art.2
L’Associazione, senza scopo di lucro, si propone di promuovere lo sviluppo dell’informatica civica sul territorio regionale attraverso:
Art.3
L’Associazione:
L’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività ritenute necessarie al conseguimento delle finalità enunciate all’art.2.
L’Associazione, che opererà in stretto collegamento con la Regione Lombardia, le Università ed altri enti di ricerca e formazione, si propone in ogni caso di valorizzare le competenze già presenti sul territorio, nonchè il processo di crescita di coloro che promuovono o vengono coinvolti nelle iniziative di informatica civica.
Per il conseguimento degli scopi di pubblico interesse sopra elencati l’Associazione si prefigge di ottenere, nelle forme che gli associati stessi definiranno, il patrocinio, la collaborazione, il sostegno degli organi dello Stato, della Regione, di altri Enti Pubblici, ivi compresa l’Unione Europea, nonché di ogni altro ente - società, associazione, fondazione - pubblico e privato.
L’Associazione potrà coinvolgere sponsor privati, con i quali saranno di volta in volta stipulate apposite convenzioni.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 4
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote dei soci, e potrà essere incrementato da contributi pubblici e privati, eredità, legati, donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata a quel fine per deliberazione del Consiglio Direttivo.
Art. 5
L’esercizio finanziario dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
ASSOCIATI
Art. 6
Gli associati si distinguono in:
Sono soci promotori: la Regione Lombardia, nonché gli altri soggetti che saranno definiti tali mediante deliberazione unanime del Consiglio Direttivo.
Sono soci fondatori il Consorzio Milano Ricerche e il LIC.
Sono soci ordinari persone o enti - in particolare province, comuni, comunità montane, associazioni che condividano le finalità enunciate all’art. 2.- , la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo.
Art. 7
Agli associati non spetta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
I soci fondatori e ordinari sono tenuti a versare le quote associative nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e gli altri eventuali contributi deliberati dall’Assemblea.
I soci promotori decideranno autonomamente secondo i rispettivi ordinamenti e strumenti normativi forme e modi del sostegno all’Associazione.
Art. 8
La qualità di Socio si perde per recesso secondo le norme del Codice Civile.
Il recesso ha luogo su domanda dell’interessato ed a seguito di presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo.
Il socio receduto non ha diritto al rimborso delle somme versate all’Associazione.
AMMINISTRAZIONE
Art. 9
Sono organi dell'Associazione:
ASSEMBLEA
Art. 10
Fanno parte dell'Assemblea tutti gli associati.
E' facoltà di ogni socio farsi rappresentare da altro associato con semplice delega scritta.
Ogni associato può essere portatore di una sola delega.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in seduta straordinaria ogni volta che lo richiedano il Presidente, la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, i soci promotori e fondatori o almeno 1/5 degli associati.
La convocazione dell'assemblea, che può avere luogo presso la sede sociale o altrove purché in Lombardia, è effettuata dal Presidente.
L’avviso di convocazione, comprende l’ordine del giorno, ed è inviato ad ogni socio con mezzo che ne possa attestare l’avvenuta ricezione nel termine di tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso può indicare il giorno di una eventuale seconda convocazione, ove nella prima non si raggiunga il numero di soci occorrenti per la legale costituzione dell’assemblea. La seconda convocazione può avere luogo anche nella stessa giornata fissata per la prima.
L'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, sia in seduta ordinaria che straordinaria, quando si è accertata la presenza in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci, in prima convocazione, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti salvo quanto specificato in seguito.
Per la validità della seduta dell'assemblea convocata per deliberare modifiche statutarie o lo scioglimento dell'ente, e per la validità delle relative delibere occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole in proprio o per delega di almeno tre quarti degli associati.
Spetta a ciascun socio promotore e fondatore la nomina di un consigliere.
Spetta all'assemblea:
Art. 11
Le Assemblee dei soci sono presiedute dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.
I verbali sono redatti dal Segretario, o, in caso di sua assenza, da un Segretario nominato dall'Assemblea e sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso.
Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due consiglieri oltre a quelli nominati dai soci promotori e fondatori.
Il numero dei componenti del consiglio direttivo varierà in conseguenza dell’ammissione di nuovi soci promotori.
In ogni caso il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere dispari; di conseguenza, ove necessario, il Presidente convocherà senza indugio l’assemblea per procedere alla elezione di un nuovo membro.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Tesoriere e/o un Segretario.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio Direttivo prima della scadenza del mandato, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio, i membri rimasti in carica debbono convocare l’Assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri dell'ordinaria e straordinaria amministrazione, delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e può delegare parte dei suoi poteri al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
Il Consiglio può nominare Comitati di consulenza tecnico - scientifici costituiti da esperti di specifiche discipline e, ove necessario, di un Direttore.
Il Consiglio Direttivo delibera con giudizio insindacabile con la maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti circa l'ammissione di nuovi soci, salvo quanto previsto all’art. 6, e circa le proposte di modifiche statutarie e di scioglimento dell'associazione da sottoporre all'Assemblea dei soci.
PRESIDENTE
Art. 15
Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi ed esercita, oltre ai poteri derivanti dallo Statuto, quelli che il Consiglio Direttivo può attribuirgli.
Al Presidente spettano i seguenti compiti:
I prelevamenti dei conti correnti sono eseguiti dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento dal Segretario-Tesoriere.
E' facoltà del Presidente promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cessazione, nonchè nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il consigliere più anziano di età.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art.16
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri e dura in carica tre anni.
Spetta al Collegio stesso il controllo periodico della contabilità e la revisione dei conti.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e può partecipare alle assemblee.
La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altro incarico nell'Associazione.
DIRETTORE
Art. 17
Potrà essere nominato un Direttore con l’incarico di provvedere all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in conformità alle direttive del Presidente, attuare, nei limiti del piano di lavoro, l’articolazione delle strutture operative dell’ente e rispondere dell’ordinato e proficuo svolgimento delle attività associative.
SCIOGLIMENTO
Art. 18
Lo scioglimento dell’Associazione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, potrà essere determinato per volontà degli associati, previa deliberazione assunta con voto favorevole dei 3/4 degli stessi e in ogni caso con il consenso dei soci promotori e fondatori.
Lo scioglimento dell’Associazione è regolato a norma di legge. L’eventuale patrimonio sarà destinato a scopi di pubblica utilità da stabilirsi dall’assemblea.
CONTROVERSIE
Art. 19
Tutte le controversie tra i soci e l’associazione o all’interno di questa sono deferite, in via esclusiva, a un Collegio Arbitrale composto da tre membri che giudicherà in via rituale secondo le norme previste in tema di arbitrato dal Codice di Procedura Civile.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20
Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.
|
|
|
|||||